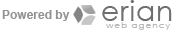Leonardo Fibonacci
Leonardo Fibonacci
un uomo che seppe, con il suo sapere, affascinare Federico II
Leonardo Fibonacci (nota 1) (Pisa 1170-1240) era figlio dell’addetto alla dogana di Bogia (Guglielmo Bonacci), in Algeria, ove i Pisani intrattenevano fiorenti traffici commerciali. Per merito del padre, apprese giovanissimo l'abaco alla maniera degli Hindi: le cifre arabe con lo zero, ancora sconosciute in Italia. Lo stesso Leonardo ci dice di aver perfezionato questa conoscenza nei suoi viaggi in Egitto, Siria, Sicilia e Provenza dove dovette recarsi per cagion di commercio.
A trentadue anni pubblicò la prima edizione del "Liber Abaci": un saggio che rivoluzionava i sistemi di numerazione, ed allo stesso tempo un manuale di calcolo ad uso dei mercanti, rivisto nel 1228 per essere dedicato a Michele Scoto (nota 2).
È del 1220 il "De practica geometriae", nel quale applicò il nuovo sistema aritmetico alla risoluzione di problemi geometrici: un trattato di Geometria e Trigonometria, con il quale ebbe avvio lo studio dei rapporti tra le estensioni figurate. Nel 1225 realizzò il "Liber quadratorum" che costituisce un brillante lavoro sulle equazioni indeterminate di 2° grado: un lavoro nel quale è visibile l'influsso della tradizione culturale araba.
Indubbiamente il Fibonacci fu il primo algebrista cristiano, il più grande matematico del medioevo, il maggior genio scientifico del XIII secolo in Italia. Egli ebbe in Federico II (cui dedicò il "Liber quadratorum") un protettore capace di comprendere le sue ricerche scientifiche e di apprezzarne il valore.
Federico II durante il suo soggiorno a Pisa nel 1226 presenziò alle gare matematiche tra Leonardo e altri matematici, in quell'occasione gli sottopose, tramite il filosofo di corte maestro Giovanni da Palermo, una serie di quesiti, avendo come risposta alcuni interessanti corollari intorno alla teoria delle frazioni (nota 3).
È stata accertata un’attiva corrispondenza scientifica tra Federico II e Fibonacci, inoltre, Leonardo fu spesso in contatto con esponenti della corte sveva.
Non è escluso che colloqui ed il successivo epistolario fra l'imperatore ed il matematico pisano abbiano potuto esercitare una certa influenza nella progettazione di Caste del Monte, ma va precisato che non c'è alcun documento che attesta il diretto coinvolgimento del Fibonacci nella progettazione del castello di Andria. Leonardo non accettò la proposta del sovrano svevo di trasferirsi alla sua corte e di farne parte; Federico II lo sostenne comunque con un lascito che gli consentì di continuare gli studi.
Il matematico pisano ebbe anche rapporti con alti prelati, ciò è dimostrato dal fatto che dedicò il trattato intitolato Flos al cardinale Raniero Capocci anch'egli cultore di matematia.
2) Michele Scoto, astronomo ed astrologo di origine scozzese che nel secondo decennio del sec. XIII operò alla corte di Sicilia.
3) Il maestro Giovanni gli sottopose alcuni problemi risolvibili con equazioni quadrate e cubiche, e le cui soluzioni furono riportate nel Flos e nel Liber quadratorum.
Note bibliografiche essenziali:
Antonino De Stefano, La cultura alla Corte di Federico II Imperatore, Edizioni all'insegna del Veltro, Parma 1990.
Ernst Kantorowicz, Federico II imperatore, Garzanti, Milano, 1988.
Eberhart Horst, Federico II di Svevia L'imperatore filosofo e poeta, Rizzoli Supersaggi, Milano, 1994.