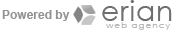La Scuola Medica Salernitana
La Scuola Medica Salernitana
Federico II era un tenace salutista e possedeva una forte passione per la medicina; curava l’igiene del proprio corpo, come dimostrano gli impianti sanitari di cui dotava le magioni imperiali, ed usava farsi accurati lavaggi anche la domenica, scandalizzando gli ambienti cristiani più osservanti.
Dalla sua Corte uscirono trattati medici capaci di segnare un vero e proprio progresso scientifico ed interessanti norme per la prevenzione delle epidemie. Uno dei suoi principali meriti, fu quello di aver saputo sviluppare la Scuola Medica Salernitana, utilizzandola per tutelare la salute pubblica ed emettere una evoluta legislazione sanitaria.
Le origini della Scuola Medica Salernitana sono antichissime e si perdono nella leggenda.
Essa affonda le radici nei primi insediamenti benedettini avvenuti nel Ducato di Benevento verso la fine dell’VIII secolo, dove i monaci diffondevano le opere mediche greche e latine ed esercitavano la professione in un ambito ristretto.
Il periodo aureo della Scuola iniziò nell’XI secolo, con l’arrivo a Salerno di Costantino l’Africano che introdusse nell’insegnamento le importanti opere arabe. Erano quelli i tempi in cui si stava affermando l’alchimia: una disciplina esercitata congiuntamente alla medicina, quindi anch’essa rientrante sotto la specializzazione della Scuola di Salerno.
Figlia della cultura alto medievale, l’alchimia, lungi dall’essere un ridicolo rito pagano, era una pratica volta alla trasformazione ed al miglioramento di tutto quanto esiste nel creato.
Dopo la prima influenza islamica, in Europa l’alchimia si è sviluppata su linee autonome con una particolare diffusione presso le Corti papali e le Case regnanti dato che le prime applicazioni si proponevano di trasformare in oro ed argento la materia vile, con il risultato di raggiungere ricchezze diversamente impensabili.
Anche se molti concetti e strumenti tecnici dell’alchimia sono diventati patrimonio della moderna chimica, le due discipline hanno più diversità che punti in comune. L’alchimista era più filosofo che scienziato, in una generale commistione delle discipline caratteristica del Medio Evo.
La Scuola Medica Salernitana ottenne i favori di Roberto il Guiscardo (1015-85), dei suoi successori normanni, degli Imperatori svevi; fu la prima a conferire un titolo accademico riconosciuto in tutti i principali Paesi europei.

Medici curano i malato, da una miniatura medievale.
Alla fine del XII secolo, la sua prosperità fu però influenzata dalle tormentate vicende politiche che colpirono Salerno. La città campana era devotissima alla Casa d’Altavilla; e nel 1189, alla morte di Guglielmo II, sostenne apertamente l’elezione al trono del Regno di Sicilia di Tancredi, contro le pretese dell’erede legittimo Enrico VI di Svevia. Morto Tancredi, Enrico VI ottenne il potere con la forza e punì la comunità infedele con saccheggi, distruzioni, deportazioni in massa di cittadini.
Con l’avvento di Federico II, Salerno non ritornò ai vecchi splendori ma riprese un’intensa attività culturale. L’Imperatore infatti non tradì il proprio stile: finanziò la ricerca scientifica e fece tradurre in latino i trattati di Claudio Galeno di Pergano (129-200 ca): il medico e filosofo greco più famoso dell’antichità dopo Ippocrate e che, con metodo sperimentale, studiò l’anatomia ed impose importanti progressi alla farmacologia, iniziando a curare varie manifestazioni patologiche.
Pur sopportando con difficoltà la concorrenza dell’Università di Napoli fondata nel 1224, la Scuola Medica Salernitana iniziò a svolgere un ruolo importantissimo nell’impostare e gestire l’intera politica sanitaria del Regno di Sicilia. Gli studiosi dell’Ateneo contribuirono in maniera determinante a formulare le norme contenute nel Liber Augustalis: la prima legislazione ad impronta costituzionale all’avanguardia in parecchi settori, non ultimo quello della salute pubblica.
Copyright © stupormundi.it