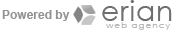BERARDO DI CASTACCA
BERARDO DI CASTACCA
Fra tutti i personaggi che per qualche motivo si possono annoverare intorno alla storia e alla figura di Federico II, un posto di rilievo, se non preminente, spetta di sicuro al suo fedelissimo Berando di Castacca. Berardo, prete trentacinquenne, che conosceva molto bene i genitori di Federico, (anzi s'era adoperato per una degna sepoltura di Enrico VI dopo la sua morte avvenuta a Messina), lo accompagnò ininterrottamente dalla sua nascita fino alla morte, nella buona e nella cattiva sorte, dividendone onori e gloria, ma anche difficoltà, scomuniche e pericoli di vario genere. In pratica, vivendo costantemente alla corte dell'Imperatore, fu dispensatore di consigli e suggerimenti verso Federico, al punto d'essere considerato come un secondo padre. La sua considerazione verso l'Imperatore fu addirittura superiore a quella che avrebbe dovuto avere verso il Papa, essendo vescovo della chiesa, e quindi arcivescovo. Lo stesso Federico ebbe a dichiarare che: "… egli in ogni circostanza fu al nostro fianco e molto sopportò per noi".
Berardo fu tra i dignitari e familiares che assistettero Federico in punto di morte, che gli impartì l'estrema unzione, e che in precedenza aveva unito in matrimonio Federico con la dolce Bianca Lancia morente.
Trasportato a Palermo, Federico venne deposto nel sarcofago di porfido rosso nel Duomo, benedetto dal fraterno amico Berardo, secondo la cronaca di Francesco Pipino: "Per manus Berardi Panormitani archiepiscopi in majori Panormitana ecclesia cum divis Augustis ejus parentibus, sicut disposuerat, honorifice tumulatum est corpus ejusdem".
Pare sia stato lui l'artefice dell'epigrafe (alcuni parlano invece di un certo chierico Trontano) apposta alla sua tomba, che così recita:
Si probitas, sensus, virtutum gratia, census,
Nobilitas orti possent resistere morti,
Non foret extinctus Fredericus, qui jacet intus.
(Se l’onestà, l’intelligenza, le più alte virtù,
la saggezza, la buona reputazione e la nobiltà
del sangue potessero resistere alla morte,
Federico, che qui riposa, non sarebbe morto)
vedi nota
Durante la minorità di Federico, il Papa Innocenzo III lo inserì nel collegio di tutela, e da lì evidentemente nacque l'afflato che l'avrebbe portato a divenire uno dei suoi più fedeli fautori e sostenitori. Berardo nel 1207 fu nominato arcivescovo di Bari, e appoggiò l'Imperatore nella strenua lotta contro Ottone IV. (La posizione di Ottone, sorretto dalle forze guelfe e dall’Inghilterra, era molto forte, e la città di Costanza già si apprestava a riceverlo con tutti gli onori, quando giunse in anticipo Federico ed il suo seguito, trovando serrate le porte della città. Solo la lettura, da parte del vescovo Berardo, del decreto di scomunica papale verso Ottone, riuscì a fare aprire le porte della città ed a farlo entrare trionfalmente, lasciando scornato Ottone, giunto poche ore dopo!).
La sua viscerale lealtà fu lodata persino da Innocenzo III, che in quel periodo andava d'amore e d'accordo con Federico.
In quegli anni le cronache lo vedono in primo piano: accompagna Federico nel suo più che avventuroso viaggio in Germania, nel 1215 sostiene i diritti di Federico contro Ottone nel Concilio Lateranense, accompagna Costanza e suo figlio in Lombardia, nel 1216. Nel 1214 era stato nominato arcivescovo di Palermo.
Grande rilievo ebbe nei rapporti di Federico con Malik al-Kamil, sultano d'Egitto. Infatti fu suo ambasciatore alla corte del sultano, dove trattò i preliminari per la Crociata, e portò in dono all'Imperatore il famoso elefante (da Federico chiamato amichevolmente 'Malik') che scorrazzò per anni per l'Italia, incutendo timore nella popolazione che mai aveva visto un simile bestione.
Manco a dirlo, accompagnò Federico nella sua crociata, e di ritorno partecipò ai negoziati per la pace di San Germano.
Nel 1235 Federico lo nominò membro del collegio dei "familiares", e seguì l'Imperatore in tutte le campagne di guerra.

1242, sottoscrizione autografa di Berardo di di Castacca, dall'Archivio di Stato di Palermo.
Nonostante la sua incondizionata devozione verso Federico, la Sede Apostolica non cessò di onorarlo della massima stima, per la sua pacatezza e irreprensibilità: ruolo che lo rendevano particolarmente adatto alla mediazione. Ragion per cui, nel 1243 Federico lo incaricò di recarsi presso il Papa, per discutere, da buon oratore, la pace con la chiesa; ma Innocenzo IV non lo volle neppure ricevere in quanto "scomunicato" per avere seguito e sostenuto un imperatore a sua volta estromesso dalla chiesa. In seguito venne assolto dalla scomunica, ma solo per portare avanti le trattative (Che commercio veniva fatto della scomunica!).
Dopo la deposizione nel Concilio di Lione, Federico era seriamente preoccupato, e per attenuare gli effetti della scomunica, fece professione di fede nelle mani dell’arcivescovo di Palermo, Berardo, del vescovo di Pavia ed all’abate di Montecassino, che, anche se a lui politicamente vicini, erano pur sempre autorità ecclesiastiche di rilievo: e questi, infatti, lo dichiararono "perfettamente ortodosso".
Il suo più grande merito fu d'avere presentato a Federico, "l'affascinante" Pier delle Vigne che, come sappiamo, fu il braccio destro dell'Imperatore in fatto di dottrina del diritto.
E non poteva mancare il lato amoroso! Si dice, infatti, che Federico sia stato l'amante di una nipote di Berardo, una certa Manna.
Fedele fino in fondo all'Imperatore, non rispose neppure alle richieste di Innocenzo IV che, tentando di riportare la chiesa del regno di Sicilia sotto l'obbedienza di Roma, cercava di trarlo dalla sua parte, a suo dire, per salvarlo dalle pene dell'inferno, data la sua veneranda età. La morte infatti lo colse, ultraottantenne, l'otto settembre del 1252, risparmiando al Papa una sicura e cocente delusione.
Nota: l'epitaffio sopra citato ora non esistente più, fu probabilmente danneggiato e tolto dalla tomba da quello stesso canonico Ruggero Paruta, che nel 1538 compose anche i versi per i sepolcri di Enrico VI e Costanza d'Altavilla.
Qui di seguito riportiamo il testo dell'epitaffio presente attualmente sulla tomba di Federico II:
Qui mare, qui terras, populos et regna subegit,
Caesareum fregit subito mors improba nomen,
Hic jacet, ut cernis, Fredericus in orbe Secundus,
Quem lapis hic, totus cui mundus paruit, arcet.
Come vedi, qui giace Federico Secondo,
che, per terra e per mare, sottomise popoli e regni,
un’improvvisa improba morte spezzò il nome di Cesare.
Questa tomba racchiude colui al quale obbedì
il mondo intero.
Copyright © Federico Messana